Ipazia
 |
| Silvia Ronchey, "Ipazia. La vera storia", Bur Rizzoli |
La storia di Ipazia è, per molti aspetti, un enigma ancora oggi, dopo 1500 anni dalla sua morte. Alcuni non sono concordi neppure sull’arma che le tolse la vita. Il libro di Silvia Ronchey intende perciò indagare la Storia e – attraverso le varie fonti pervenute fino a noi – ricostruire la storia di questa donna straordinaria. Forte, intelligente, saggia, coraggiosa, Ipazia è stata definita in molti modi. Qualcuno sostiene sia stata una pioniera in molti campi, tra i quali quello astronomico. Una donna autorevole e potente. Le certezze su di lei sono veramente poche, ma un punto almeno è appurato: fu assassinata in modo brutale e orribile. Aggredita per strada, spogliata nuda, trascinata per un buon tratto di strada, dilaniata con cocci aguzzi; mentre agonizzava, le furono cavati gli occhi, poi fu smembrata e ciò che rimaneva di lei fu arso su un rogo. “Il rogo di Ipazia è stato da alcuni considerato il primo esempio di caccia alle streghe dell’inquisizione cristiana. In effetti il proselitismo armato di Cirillo contraddiceva in pieno la pur astratta idea di tolleranza propugnata cento anni prima dall’editto di Costantino del 313, così come la tendenza conciliatoria del cristianesimo con il paganesimo d’élite che il primo imperatore cristiano avena appoggiato politicamente e sancito giuridicamente”.[1]
A compiere il massacro, a quanto pare, furono fanatici cristiani, fomentati dall’odio – o, forse, dall’invidia – dell’arcivescovo Cirillo d’Alessandria il quale, perciò, viene considerato il “mandante” del femminicidio in questione. Ciononostante, fu proclamato Santo. Infatti non tutti sono concordi nel ritenere Cirillo responsabile – direttamente o indirettamente - della morte di Ipazia, anche se numerose sono le fonti che lo vedono coinvolto nei fatti.
Ancora oggi ci si interroga su chi fosse davvero Ipazia, su come sia stata uccisa, da chi e per quale motivo. Ci si chiede cosa insegnasse veramente e se tali insegnamenti fossero tanto pericolosi da doverla mettere a tacere per impedirle di portare avanti la propria opera. Su di lei circolano voci e leggende dal sapore romantico, racconti dall’aura mitica e anche un po’ mistica, non sempre verosimili e ancor più raramente credibili. Propaganda, maldicenze, falsità e mistificazioni, parzialità e inesattezze; compresi errori di traduzione. Un esempio fra tanti fraintendimenti dovuti ad errate traduzioni è quello che parla dell’arma usata dai suoi carnefici per ucciderla. Cocci, non conchiglie dilaniarono le carni di Ipazia; e confondere gli uni con le altre porterebbe ad accusare le persone sbagliate…
“La storia di un evento è composta dalla somma dei dati fattuali di quell’evento e delle trasformazioni, interpolazioni, manipolazioni che via via ne sono susseguite, fino a formare parte integrante dell’evento stesso. Più lo si studia più lo si svela diverso da come è stato tramandato. E si intuisce che non sarà mai interamente ricostruibile, perché l’infiltrazione della propaganda comincia già subito con la sua primissima narrazione storica.
L’evento in sé e per sé, tale quale si è prodotto, non riusciremo mai veramente a ricostruirlo”.[2]
“[…] occorre dissezionare giudizi e pregiudizi, e attaccare il mistero su due fronti: da un lato, quello della filologia – ripristino di quanto più possibile in termini di dati positivi ed esegesi delle fonti -, d’altro lato quello dell’ideologia – analisi delle deformazioni presenti sia in quelle fonti stese, sia nella storia degli studi che ne derivano e nella produzione letteraria generata da questi ultimi”.[3]
Il libro si compone di tre parti: una prima parte dal carattere e dallo stile leggermente “romanzato”, che racconta i fatti in modo più lineare, ma non per questo privo di dubbi e interrogativi; una seconda parte tutta iconografica; e, infine, una terza sezione – che è quasi un testo a sé – che riprende, specifica e approfondisce dati, fonti e fatti dai quali è stato tratto il materiale utilizzato per la composizione della prima parte. Il libro scandaglia tutti i dati a disposizione per cercare di ricostruire una versione più fedele possibile alla realtà dei fatti accaduti a Ipazia, ma anche per provare a dare un quadro più verosimile della donna che era. In tutto questo non mancano gli aneddoti intriganti e avvincenti.
Ipazia fu innanzitutto una filosofa, ma nei secoli la sua figura è stata insignita di molti altri ruoli, la sua persona strumentalizzata per asservire agli scopi del momento. Divenne quindi “scienziata punita per le sue scoperte, eroina protofemminista, martire della libertà di pensiero, illuminista e romantica, libera pensatrice e socialista, protestante, massone, agnostica, vestale neopagana e perfino santa cristiana. Ma Ipazia non era nulla di tutto questo”.[4]
“Nell’Alessandria del V secolo, Ipazia apparteneva all’aristocrazia intellettuale della scuola di Plotino e Porfirio e dalla tradizione familiare aveva ereditato la successione (diadoche) del suo insegnamento. Una cattedra pubblica, in cui insegnava «a chiunque volesse ascoltarla il pensiero di Platone e di Aristotele e di altri filosofi», come narrano le fonti antiche. In questo senso era anche una scienziata: la sapienza impartita nelle scuole platoniche includeva la scienza dei numeri e lo studio degli astri. Era dunque anche una matematica e un’astronoma, ma nel senso antico e prescientifico. Non fece alcuna scoperta, non anticipò nessuna rivoluzione copernicana, non fu una Galileo donna. Tutto quello che sappiamo è che costituì devotamente il testo critico del terzo libro dell’Almagesto di Tolomeo, perché suo padre Teone potesse svolgerne il commento, e compose di persona commentari didattici a quelli che erano i libri di testo dell’epoca: le Coniche di Apollonio di Perga e l’Algebra di Diofanto. Non certo per questo fu assassinata.
Oltre che una filosofa platonica Ipazia era una «gran maestra» dal carisma quasi sacerdotale. C’era, nelle accademie platoniche, un risvolto esoterico, che implicava la trasmissione di conoscenze «segrete» - nel senso di non accessibili ai principianti, ma solo a una cerchia ristretta di iniziati – che riguardavano il divino. Oltre all’insegnamento pubblico (demosia), che teneva presso il Museo o altrove nel centro della città, sappiamo di riunioni «private» (idia), che teneva nella sua dimora, in un quartiere residenziale fuori mano, verde di giardini. Fu nel tragitto in carrozza tra l’uno e l’altra che venne aggredita e uccisa. La furia dell’arcivescovo Cirillo, che secondo la testimonianza pressoché unanime delle fonti coeve fu il mandante del suo assassinio, venne scatenata proprio dalla scoperta di queste riunioni.
Perché queste riunioni portavano Ipazia al centro della vita non solo culturale ma anche istituzionale di Alessandria. Perché stringevano in un sodalizio non solo intellettuale ma anche politico le élite pagane della città, convertite al cristianesimo per necessità, dopo che i decreti teodosiani lo avevano proclamato unica religione di Stato, ma unite dalla volontà di conservare le proprie tradizioni e convinzioni: quell’«educazione ellenica» che si chiamava ancora paideia, quel «modo di vita greco» che il discepolo prediletto di Ipazia, Sinesio, definiva «il metodo più fertile ed efficace per coltivare la mente».
Alle riunioni di questa «eterìa» (hetaireia) o «fratellanza» (phratria) in cui la classe dirigente alessandrina, pagana, cristiana e forse anche ebraica si stringeva per far fronte al cambiamento e tutelare i propri interessi nel trapasso dall’una all’altra egemonia di culto e pensiero, partecipavano anche i membri della classe dirigente inviati dal governo centrale di Costantinopoli. «I capi politici venuti ad amministrare la polis erano i primi ad andare ad ascoltarla a casa sua. Perché, anche se il paganesimo era finito, il nime della filosofia sembrava ancora grande e venerabile a quanti avevano le massime cariche della polis.»
Anche il prefetto augustale Oreste apparteneva a quella cerchia più riservata, se non segreta, in cui Ipazia prodigava insegnamenti […].
Ipazia non era solo maestra e direttrice di coscienza dei quadri politici. Era una politica lei stessa. Le fonti la descrivono «eloquente e persuasiva (dialektike) nel parlare, ponderata e politica (politike) nell’agire, così che tutta la città aveva per lei un’autentica venerazione e le rendeva omaggio». Lo stile dei suoi discorsi era così franco da essere secondo alcuni elegantemente insolente. Era spesso la sola donna in riunioni riservate agli uomini, ma la compagnia maschile non la metteva in imbarazzo né la rendeva meno impassibile e lucida della sua dialettica. «Ipazia non aveva remore ad apparire alle riunioni degli uomini. Anzi, per la sua straordinaria saggezza tutti i maschi le erano deferenti e la guardavano, se mai, con stupore e timore reverenziale». «Dall’educazione ellenica le derivavano un autocontrollo e una libertà di parola (parrhesia) che le permettevano di affrontare faccia a faccia, con la stessa imperturbabilità, anche i più potenti».
Ipazia interveniva in senso pacificatore negli affari della città e principalmente nelle lotte religiose che la insanguinavano. […] Poco prima di venire assassinata aveva difeso l’antica comunità ebraica di Alessandria dal devastante pogrom ordinato da Cirillo, la cui azione politica aveva due linee ben precise: la lotta economica contro gli ebrei, che dominavano il trasporto del grano da Alessandria a Costantinopoli, e la tendenza a «erodere e condizionare il potere dello Stato oltre ogni limite mai concesso alla sfera sacerdotale».
Solo questo la tolleranza di Ipazia non tollerava, e su questo l’Ipazia politica era inflessibile quanto era flessibile l’Ipazia filosofa: l’ingerenza di qualunque Chiesa sul potere laico dello Stato. Bastò questo, con ogni probabilità, a motivare il suo assassinio, che fu a tutti gli effetti un assassinio politico. Nulla a che fare con la scienza […]”.[5]
Per quale motivo – oggi più che mai – è importante ripercorrere le orme di questa donna ce lo dice la Storia stessa che dopo 15 secoli da quei fatti terribili ancora è testimone di discriminazioni, violenze, ingiustizie, oppressioni e barbarie ai danni di donne, ma anche di uomini e – vorrei aggiungere – di tutte le creature viventi.
“Oggi il simbolo di Ipazia non è più di élite ma di massa”.[6]
Di cosa fu vittima, Ipazia? Di un assassinio politico, religioso o dal carattere più “personale”? Galeotta fu una gara d’appalto? O, piuttosto, il suo tentativo di tenere separati i poteri di Stato e Chiesa? Fu per invidia, per gelosia, per paura o per eliminare la “concorrenza” che Ipazia venne assassinata? o, forse, c’erano prove a supporto di un suo operato legato alla «magia»? I pagani usano i termini del sacrificio, mentre i cristiani quelli del martirio. Ipazia è diventata un simbolo dalle tante facce, una figura ampiamente stratificata e ramificata, ma soprattutto della libertà di pensiero. La sua eco è giunta a noi portando messaggi differenti per ognuno: c’è chi sente in quella voce lontana un annuncio dai tratti femministi – la donna è diversa dall’uomo ma non gli è inferiore - e chi una spinta motivazionale – studia, impegnati e lotta per il raggiungimento dei tuoi obiettivi; c’è chi vi legge una sfumatura politica – i laici allo Stato, i religiosi alla Chiesa - e chi una chiara pennellata di progresso scientifico o filosofico. Anche se le due cose non andrebbero disgiunte. Ad ogni modo è chiaro che le persone che pensano sono da sempre ritenute pericolose da coloro che detengono una qualsiasi forma di potere proprio perché temono di perdere il loro status. In questo senso coloro che insegnano a pensare sono ritenuti altrettanto pericolosi. Ipazia era una di questi? Di sicuro sappiamo che è vissuta nell’intercapedine tra due epoche: da una parte quella morente dell’impero romano, dall’altra quella nascente dell’impero bizantino. Non solo. Ha assistito anche a uno scontro tra due civiltà: quella pagana e quella cristiana; scontro che poi si risolse nella loro integrazione. Anche sulle sue materie di studio/insegnamento c’è molta confusione, ma stando all’opera stessa di Teone[7] e Ipazia è possibile ritenere che padre e figlia non insegnassero il platonismo teoretico, “bensì il suo avviamento tecnico-matematico, geometrico, astronomico”.[8]
“Ipazia doveva essere, […], «versata nella geometria». Ma, se la testimonianza del titolo conferma la sua indubitabile attività di scienziata e studiosa, è arbitrario e fantasioso dedurne l’esistenza di sue osservazioni astronomiche anticipatrici della rivoluzione scientifica moderna”.[9] Nessuna ‘rivoluzione ipaziana’ e nessun «sistema ipaziano», dunque.
E non era una filosofa qualunque: i suoi insegnamenti erano intrisi di esoterismo e sacralità.
Anche sulle invenzioni a lei attribuite c’è da sfatare qualche mito. “Le sole invenzioni di Ipazia di cui possiamo essere certi sono le macchine che faceva costruire agli allievi: un astrolabio piatto, considerato oggi dagli scienziati alquanto banale, un idroscopio, che avrebbe attirato invece l’attenzione del grande matematico Pierre Fermat, e un aerometro, per attenerci a quanto riferito da Sinesio. Tutto il resto è illazione, o congettura”.[10]
Resta il fatto che Ipazia era potente. Il suo carisma aveva destato ammirazione, certo, ma anche invidia. Ipazia aveva le attenzioni delle persone che contavano e le sue lezioni si dividevano tra quelle «pubbliche» (demosia) e quelle private. Queste ultime erano solo per pochi eletti perché per via degli argomenti trattati e del loro livello di difficoltà. Tanto è vero che, stando alla testimonianza di Sinesio, Ipazia fu alla guida della confraternita platonica – dal carattere esoterico - più importante della sua epoca. Una sorta di protomassoneria, insomma, di cui Ipazia rappresentava il vertice.
“Ma su un punto non si può non essere concordi: a qualunque cosa Ipazia sia somigliata di più, a una studiosa o a una sacerdotessa, a una composta insegnante o a un’aristocratica eccentrica e trasgressiva; che sia stata giovane o no, che abbia fatto o no davvero innamorare i suoi allievi, che abbia o no – non è escluso – scoperto qualcosa di nuovo; che l’insegnamento iniziatico da lei impartito con tanto successo all’inquieta élite ellenica offrisse o no già la rivelazione che a un livello alto la teologia platonica inglobava quella cristiana e che gli improbabili dogmi di quest’ultima andavano tollerati, praticando l’arte platonica della «nobile bugia», perché utili al popolo quanto ogni antica superstizione pagana; che sia stata risoluta nello sbarrare il passo all’ingerenza della Chiesa nello Stato e troppo ingombrante nello sfidare la strategia di Cirillo con la sua parrhesia, o che la sua morte sia stata solo un incidente dovuto al subitaneo isterismo di un influente prelato cristiano ottenebrato dall’emulazione e dall’ambizione, oltreché al momentaneo disorientamento di un prefetto augustale romano messo in difficoltà da un vuoto di potere imperiale; in ogni caso, ogni volta che nella storia si ripropone, e si ripropone spesso, il conflitto tra un Cirillo e un’Ipazia, una cosa è certa: siamo e saremo sempre dalla parte di Ipazia”.[11]
[1] Silvia Ronchey, “Ipazia. La vera storia”, Bur Rizzoli, p. 14 (Introduzione)
[2] Silvia Ronchey, “Ipazia. La vera storia”, Bur Rizzoli, p. 200
[3] Silvia Ronchey, “Ipazia. La vera storia”, Bur Rizzoli, p. 201
[4] Silvia Ronchey, “Ipazia. La vera storia”, Bur Rizzoli, p. 10 (Introduzione)
[5] Silvia Ronchey, “Ipazia. La vera storia”, Bur Rizzoli, pp. da 10 a 14 (Introduzione)
[6] Silvia Ronchey, “Ipazia. La vera storia”, Bur Rizzoli, p. 17 (Introduzione)
[7] Teone, padre di Ipazia.
[8] Silvia Ronchey, “Ipazia. La vera storia”, Bur Rizzoli, p. 163
[9] Silvia Ronchey, “Ipazia. La vera storia”, Bur Rizzoli, p. 163
[10] Silvia Ronchey, “Ipazia. La vera storia”, Bur Rizzoli, p. 164
[11] Silvia Ronchey, “Ipazia. La vera storia”, Bur Rizzoli, pp. 207-8

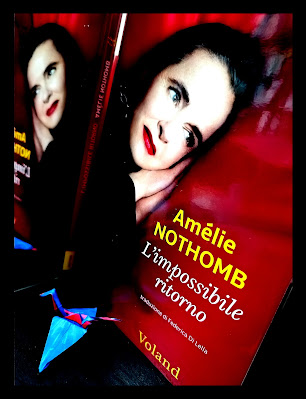
Commenti
Posta un commento
Lasciami un segno del tuo passaggio scrivendo un commento: per me, ogni interazione è importante!